Etica e bioetica
“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi.”
Marcel Proust
Si dice che la vita sia un viaggio che non procede mai in modo lineare: spesso ci troviamo davanti a un bivio; pertanto, siamo chiamati a scegliere da che parte andare, quale direzione prendere e perché prenderla.
Questo percorso vuole essere di supporto ai giovani, in riferimento alle Linee guida ministeriali per l’Orientamento post diploma, Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022 – Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022 – Miur , ma anche a tutti coloro che desiderano un aiuto per orientarsi nelle proprie scelte di vita.
Il percorso è strutturato in un cammino che, partendo dal piano esperienziale, guiderà i fruitori in una successione di tappe che possono essere affrontate sia singolarmente, sia progressivamente in modo unitario. Ciò che si vuole favorire è la sperimentazione di alcuni semplici esercizi di discernimento per una prima maturazione della scelta morale a livello individuale e sociale.
Nella parte conclusiva, alcune proposte di temi di bioetica per una possibile applicazione di quanto è stato maturato e appreso.
A guidare questo cammino esistenziale è la voce autorevole dell’Arcivescovo Carlo Maria Martini, il cui magistero si è distinto per la profonda sensibilità per le questioni educative.
Introduzione
Il proposito di Carlo Maria Martini
Non intendo, in questa sede, fare un trattato di morale; mi limiterò semplicemente a cercare con voi il significato di qualcuna delle parole-chiave che occorrono allorché bisogna dare giudizi corretti su comportamenti amministrativi, sociali, politici, quando cioè sono in gioco le nostre responsabilità verso la collettività. […]
Mi pare che stiamo vivendo una stagione propizia per tali chiarimenti. L’avventura linguistica potrebbe perciò diventare anche avventura dello spirito. Purché la si corra con la mentalità giusta: quella di un sano ottimismo.
Carlo Maria Martini, Viaggio nel vocabolario dell’etica, Edizioni Piemme, AL 1993, pp. 11-13.

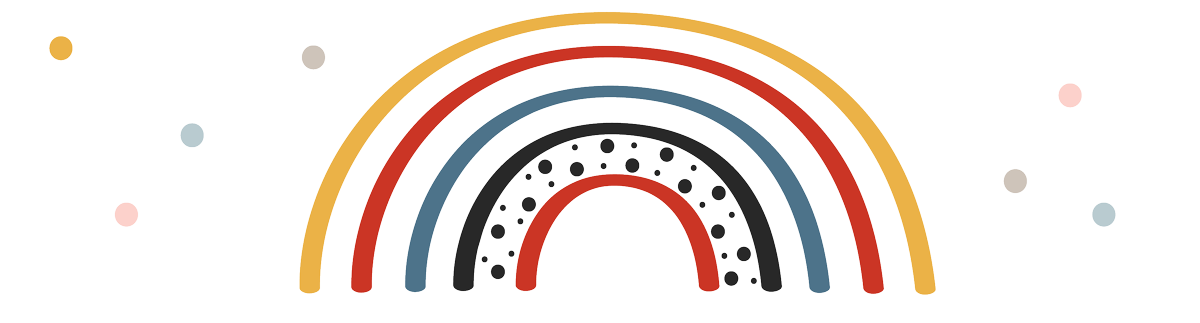
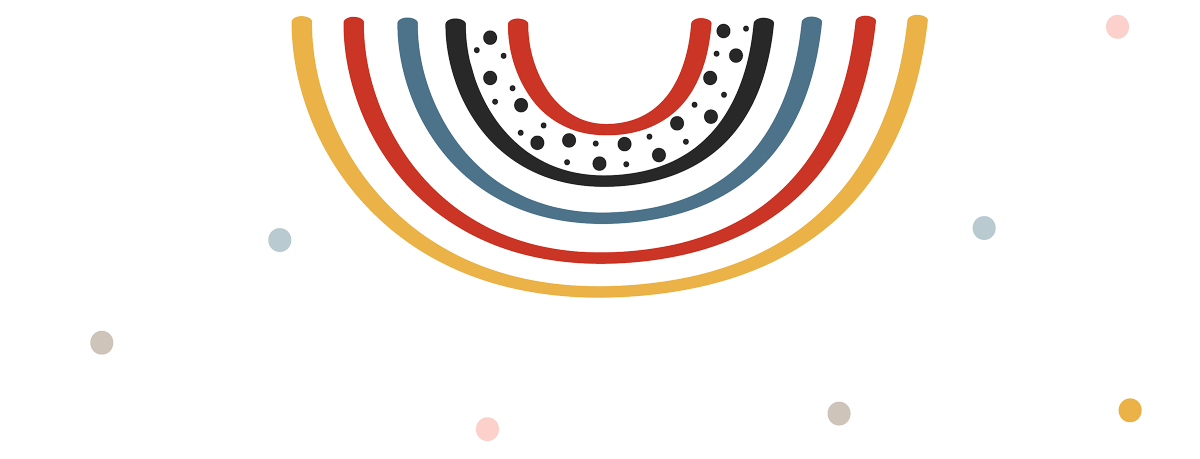
Il percorso a tappe
AVVIO DEL PERCORSO
Noia e/o inquietudine, due possibili condizioni di esistenza
Obiettivo
Avviare la capacità di riflettere su di sé e sul proprio stato emozionale per scoprire l’importanza della propria interiorità.
1. Annoiarsi
Esercizio preliminare
Prova a togliere tutto ciò che hai sul banco; mettiti in una condizione di silenzio e lascia che il tempo scorra… Dopo circa 5 minuti, ascolta queste canzoni:
| Angelina Mango, La noia Jovanotti, Tempo Luigi Tenco, Un giorno dopo l’altro |
Proviamo a riflettere
- Ti capita di annoiarti? Quando ti coglie la noia?
- Quella volta mi sono annoiato davvero… (racconta brevemente)
- Ti piace stare nella noia?
- Ascolta nuovamente le tre canzoni proposte e scegli quella che ti sembra rappresentare meglio la noia che hai provato/che provi.
- Leggi i testi qui di seguito proposti e dai un voto da 1 a 3 (1 per niente, 3 molto) a quello che più si avvicina a ciò che pensi riguardo la noia.
Noia. Niente è insopportabile all’uomo quanto l’essere in pieno riposo, senza passioni, senza occupazioni, senza divertimenti, senza faccende. Sente allora la sua nullità, il suo abbandono, la sua insufficienza, la sua dipendenza, la sua impotenza, il suo vuoto. E subito sorgeranno dal fondo della sua anima la noi, l’umor nero, la tristezza, il cruccio, il dispetto, la disperazione.
Blaise Pascal, Pensieri, 79, BUR, Milano 2011.
La condizione che caratterizza ragazzi e ragazze del nostro tempo, afflitti da assenza di interessi, monotonia delle impressioni, sensazioni di immobilità, vuoto interiore, rallentamento del corso del tempo.
Umberto Galimberti, L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Feltrinelli, Milano 2008.
Senso di insoddisfazione, di fastidio, di tristezza, che proviene o dalla mancanza di attività e dall’ozio o dal sentirsi occupato in cosa monotona, contraria alla propria inclinazione, tale da apparire inutile e vana: […] Anche, il senso di sazietà e di disgusto che nasce dal ripetersi di cose uguali o uniformi: […] di cosa che ingenera fastidio, senso di nausea, o addirittura di avversione.
Enciclopedia Treccani, voce Noia
Attività
Parlate in classe delle vostre scelte.
Uscire dalla noia
Ciò che mi colpiva, soprattutto, era che non volevo fare assolutamente niente, pur desiderando ardentemente di fare qualche cosa.
Alberto Moravia, La noia, Bompiani, Milano 1960.
2. Essere inquieti
Esercizio preliminare
Prenditi una pausa, in un luogo e in una situazione per te comoda e prova ad ascoltarti: cosa senti dentro di te? Tranquillità o mancanza di tranquillità? Dopo circa 5 minuti ascolta queste canzoni:
| Tiromancino (feat. Fabri Fibra), L’inquietudine di esistere Laura Pausini, La solitudine Nek, L’inquietudine |
Proviamo a riflettere
- Ti piace essere inquieto?
- Quando senti, dentro di te, l’inquietudine sei spaventato oppure hai la sensazione di essere più forte?
- Ascolta nuovamente le tre canzoni proposte e scegli quella che ti sembra rappresentare meglio l’inquietudine che hai provato / che provi.
- Leggi i testi qui di seguito proposti e dai un voto da 1 a 3 (1 per niente, 3 molto) a quello che più si avvicina a ciò che pensi riguardo l’inquietudine.
Vedo quegli spaventosi spazi dell’universo, che mi rinchiudono; e mi trovo confinato in un angolo di questa immensa distesa, senza sapere perché sono collocato qui piuttosto che altrove, né perché questo po’ di tempo che mi è dato da vivere mi sia assegnato in questo momento piuttosto che in un altro di tutta l’eternità che mi ha preceduto e di tutta quella che mi seguirà. Da ogni parte vedo soltanto infiniti, che mi assorbono come un atomo e come un’ombra che dura un istante, e scompare poi per sempre. Tutto quel che so è che debbo presto morire; ma quel che ignoro di più è, appunto, questa stessa morte, che non posso evitare.
Blaise Pascal, Pensieri, 194
Tutta l’infelicità umana viene da una sola cosa, cioè dal non sapere stare in riposo in una stanza.
Blaise Pascal, Pensieri, 126
Vivere in crisi è vivere inquieti, ma tutta la vita si vive inquieti; nessuna vita, mentre la si vive, è calma e tranquilla, per quanto lo si desideri. Se essa oltrepassa il limite della sopportazione, ad altri dobbiamo chiedere aiuto, ma se essa ci scaturisce da dentro e riesce a vigiliare sulle paure che vengono dal mondo, allora l’inquietudine è attività liberatrice.
Maria Zambrano, Verso un sapere dell’anima, Raffaello Cortina, Milano 1996, p. 80.
L’inquietudine, quali ne siano le sue ragioni, è […] quanto di meglio la storia umana abbia saputo esprimere. Che cosa sarebbe la cultura senza questa anima sottile o eccitante, che seduce una generazione dopo l’altra, la parte migliore di ogni giovinezza? che ne sarebbe della scienza, della filosofia, dell’arte senza chi ne seppe interpretare ogni volta i rischi? che ne sarebbe della vita di ciascuno, se – almeno una volta […] – l’irriducibile voglia di provare, decidere, cambiare, riamare, abbandonare, fuggire non avesse conosciuto il suo corso? Non avrebbe vissuto la sua epopea, seppur breve e fugace.
Duccio Demetrio, Autoanalisi per non pazienti. Inquietudine e scrittura di sé, Raffaello Cortina, Milano 1996, p. 6.
Attività
Parlate in classe delle vostre scelte.
Uscire dall’inquietudine
L’impulso creativo che abita l’inquieto sentire e pensare, da assecondare e risvegliare nel corso della vita, quasi un appuntamento annunciato, è dunque la medicina, senza controindicazioni, di chi sa risollevarsi da delusione e cadute.
Duccio Demetrio, Autoanalisi per non pazienti. Inquietudine e scrittura di sé, Raffaello Cortina, Milano 1996, p. 7.
Come fai ad uscire dall’inquietudine? Proveremo a darti qualche suggerimento.
3. Un chiarimento: la differenza fra irrequietudine e irrequietezza
Ciò che distingue l’inquietudine dell’irrequietezza è il rapporto di questi stati d’animo con la nostra interiorità.
Mentre l’irrequietezza sembra mostrarsi nei comportamenti verso il mondo, verso l’esterno, quasi a farci fuggire dall’interiorità, l’inquietudine può essere un tratto dell’interiorità: è il sentimento che accompagna l’incertezza, una certa insoddisfazione di sé per andare oltre sé stesso, un intimo travaglio, un’attesa di qualcosa di migliore.
È per l’inquietudine del suo cuore – diceva Ignazio Silone – che si può nutrire fiducia nell’uomo.
4. Intranquillità e interiorità: una riflessione critica
Per cosa facciamo tutto quel che facciamo? Il vivente è sempre intranquillo, deve continuare ad agire per continuare a essere. Ma l’intranquillità non può bruciare la nostra interiorità. Cerchiamo di capire perché… nel percorso puoi riflettere leggendo due brani che consigliamo.
Per approfondire: M. Benasayag, T. Cohen, L’epoca dell’intranquillità, Lettera alle nuove generazioni, Vita e Pensiero, Milano 2024.
5. Uscire dalla noia e dall’inquietudine: il valore e l’importanza di agire
Ti suggeriamo di leggere le parole di Carlo Maria Martini che illustrano il valore dell’agire e della libertà:
Agire
La modalità dell’avere ha certamente elementi positivi; essa svela il bisogno insito nella persona di espandersi e di disporre di strumenti.
Ma là dove l’avere sembra esprimere tutta la sua forza […], allora nasce la conclusione: Io sono in quanto ho; ciò che ho – denaro, prestigio, potere, influenza – è ciò che mi qualifica, che mi fa semplicemente essere. Agire è più che acquistare potere, è più che dominare ed è più che possedere; è scrivere la pagina della propria libertà e della propria dignità sul terreno duro dei processi storici. Allora, la vita delle persone, il loro incontro e il loro comunicare si aprono alla questione dei significati ultimi. Al di là dell’autonomia e del potere, si fa strada lo spazio della libertà, la possibilità del riconoscimento dell’altro, del dono di sé.
Carlo Maria Martini, Denaro e coscienza cristiana, Relazione al Convegno della Chiesa di Bologna, Bologna, 10-4-1987, pp. 12-13; in Carlo Maria Martini, Parole per l’anima. Dizionario spirituale, PIEMME, Milano 2017, pp. 12-13.
Libertà
Il manifesto della libertà interiore sono le Beatitudini, cioè l’atteggiamento profondo di distacco da ciò che si possiede (denaro, successo, potere, progetti, pretesa di gestire la propria vita). Per la pretesa di gestire la vita nostra e altrui, senza lasciare uno spazio di distacco nel profondo, noi diventiamo schiavi delle cose, degli impegni, delle aspettative degli altri, dell’immagine che gli altri hanno di noi. […]
Questa libertà è progressiva perché richiede molti anni, molta fatica, molte tribolazioni per acquistarla; non ci è data subito.
Siamo dunque in cammino verso la vera libertà […].
Si tratta di un cammino che coinvolge tutta la nostra esistenza; […].
La purificazione attiva consiste […] nel saper scegliere, e quindi anche nel saper rinunciare quando è necessario, alla luce di criteri di bene superiore.
Carlo Maria Martini, Di quale libertà Cristo ci ha liberati?, Meditazione all’incontro con i politici, Milano, 15-12-1991; in Carlo Maria Martini, Parole per l’anima. Dizionario spirituale, PIEMME, Milano 2017, pp. 103-104.
Proviamo a riflettere
- Le riflessioni proposte aprono al problema della scelta, necessaria per intraprendere una qualsiasi azioneche possa favorire la crescita della propria interiorità e della relazione con gli altri.
- Il problema della scelta è sempre accompagnato da alcuni interrogativi, tipici di ogni riflessione etica:cosa vuol dire scegliere? Come si fa a scegliere? Si può scegliere bene? Ma esiste il bene? Se esiste, che cos’è? E poi è bene solo per me o anche per gli altri (uomini, animali, piante…)?
Attività
Lavoro a gruppi: ogni gruppo prova ad elaborare una o più risposte alle domande qui sopra suggerite per poi confrontarsi con gli altri gruppi.
IL PRIMO PASSO
La scelta
Un viaggio di mille miglia deve cominciare con un solo passo.
Lao Tzu
Obiettivo
Ti invitiamo a riflettere su come maturano le tue scelte e su quali sono i parametri o fattori che ti guidano.
1. Per iniziare: scelte quotidiane e/o scelte importanti
Le scelte quotidiane
Cosa ti muove nella tua giornata quotidiana? Prendi in esame alcune azioni che fai durante il giorno; per esempio: in base a che cosa decidi come vestirti o se comprare e avere un certo tipo di cellulare? Pensi sia il desiderio, il piacere, la necessità, il dovere, il consenso altrui, ecc. …
Attività
Diario delle scelte per riflettere sulle proprie azioni quotidiane e sulle motivazioni che le determinano (piacere, dovere, necessità, moda, pressione sociale…).
Istruzioni:
- Durante una giornata (a casa e a scuola), osserva alcune delle scelte che fai.
- Per ciascuna scelta, scrivi:
• L’azione compiuta (esempio: “Ho indossato le scarpe da ginnastica”)
• L’alternativa scartata (esempio: “Scarpe eleganti”)
• Il motivo principale della tua decisione (scegli tra: piacere, dovere, necessità, pressione sociale, moda, abitudini) - Porta la scheda in classe per condividerla e confrontarla con i compagni.
Le scelte importanti
Oltre a quelle che sono le tue scelte quotidiane, ti sarà capitato di aver fatto una scelta importante. Prova a pensare e a individuare una, o più, situazioni importanti da te vissute.
- In quale contesto è accaduto?
- Qualcuno ti ha aiutato a scegliere?
- Che cosa è scattato dentro di te che ti ha portato alla scelta?
- Oggi pensi che quella scelta ti abbia soddisfatto?
- Quando decidi qualcosa, cosa cerchi? per es. di stare meglio (felicità)? di fare star meglio qualcun altro(anche se mi costa qualcosa)?
- Se tu potessi tornare indietro, rifaresti la stessa scelta?
Attività
Timeline delle Scelte – Diario Illustrato
Ognuno riceve un foglio e disegna una linea del tempo della propria vita, dai primi ricordi fino a oggi. Su questa linea devono essere segnate almeno 5 scelte significative (grandi o piccole, esempio: “ho scelto di cambiare gruppo di amici”, “ho deciso di dire la verità”, “non ho seguito il branco”, “ho scelto una scuola invece di un’altra”). Ora hai davanti a te un primo bilancio della direzione intrapresa dalla tua vita!
2. Approfondiamo insieme a Carlo Maria Martini e a Sorën Kierkegaard
Per aiutarti a comprendere cosa sia la scelta e cosa significhi scegliere, ti proponiamo la lettura di alcune pagine di Carlo Maria Martini e del filosofo Sorën Kierkegaard.
Scelta
Con il sostantivo “scelta” si esprime la consapevolezza di una libertà […]. Non è semplicemente un dilemma drammatico, tra bene e male, ma è una continua progressione e un’attenzione ai tanti beni e alle tante realtà, diffuse nel mondo […], in vista di una scelta pienamente edificativa e costruttiva della società. L’impegno a scegliere, che è sostanziale, mette in evidenza una responsabile libertà, e non un arbitrio solitario non correlato a nessuno e privo di criteri di riferimento.
Carlo Maria Martini, La spiritualità laicale, nel II anniversario della morte di Vittorio Bachelet, 12-2-1982; in Carlo Maria Martini, Parole per l’anima. Dizionario spirituale, PIEMME, Milano 2017, pp. 189-190.
La scelta è decisiva per il contenuto della personalità; con la scelta essa sprofonda nella cosa scelta e se essa non sceglie, appassisce in consunzione.
Sorën Kierkegaard, Aut-aut in www.treccani.it
Attività
Rifletti sui brani: sottolinea i concetti fondamentali e discuti/confrontati con i tuoi compagni.
3. Come si fa a scegliere
Premessa: l’etica cos’è?
Proviamo, innanzitutto, a precisare che cosa possa essere l’etica:
[…] l’etica è una riflessione che riguarda l’agire (in quanto consapevole, libero e responsabile, nella sua dimensione interiore ed esteriore, personale e comunitaria) in vista di vivere la felicità e il senso. Nell’etica, l’oggetto proprio della riflessione è l’agire. Si tratta dell’agire umano, cioè non meccanico e deterministico, ma che implica le capacità proprie dell’uomo: consapevolezza, libertà e responsabilità. Quell’agire alla cui sorgente c’è la persona, considerato non solo nella sua dimensione esteriore, ma anche nella sua genesi interiore.
Carlo Casalone SJ, inedito.
Tieni sempre presente che la riflessione etica si sviluppa in modi diversi, per cui non esiste una sola nozione di etica: siamo in un contesto pluralista riguardo alle nozioni proprio dell’etica come bene, giustizia, libertà … ed è per questo che riflettere sull’etica è importante per capire quale direzione vogliamo che abbia il nostro cammino di vita.
… e ancora…
L’uomo è un essere in cammino e bisognoso di significato: fino a quando non l’ha trovato è triste, annoiato, nervoso, iroso con se stesso e con gli altri.
L’uomo si chiede il senso del progresso economico e industriale che abbiamo vissuto, il senso dell’attuale crisi che stranamente si pone come smentita della fiducia riposta nel progresso industriale […] perché dare fiducia agli altri se poi tanta gente manca di fiducia? che senso ha la fedeltà? […]. L’uomo avverte questo terribile contrasto e va alla ricerca di un’ipotesi più ampia, che accolga le contraddizioni della storia e riveli però la possibilità di comprenderle. L’uomo non si rassegna alla possibilità di essere colpito personalmente dalla malattia, […] non si rassegna alla morte, che colpisce gli altri mentre sono ancora giovani, con famiglia a carico, ecc. L’uomo si chiede il senso di tutto questo dolore, il senso della vita: forse non sarà sempre un senso religioso che cerca, ma è ugualmente molto importante fare cammino, accompagnarsi a quest’uomo alla ricerca di senso.
Carlo Maria Martini, La Lectio Divina, Al clero di Venezia, 2-12-1982, in Carlo Maria Martini, Parole per l’anima. Dizionario spirituale, PIEMME, Milano 2017, pp. 192-193.
La possibilità di scegliere
Il filosofo danese Kierkegaard spiega che la scelta è legata alla possibilità: se non ci sono possibilità di scelta, è evidente che non si possa scegliere! La possibilità, però, non si manifesta subito come possibilità di riuscita della propria scelta, infatti:
Di solito la possibilità di cui si dice ch’è così lieve, s’intende come possibilità di felicità, di fortuna, ecc. Ma questa non è affatto la possibilità; questa è un’invenzione fallace […] No, nella possibilità tutto è ugualmente possibile […] la possibilità è la più pesante di tutte le categorie.
Sorën Kierkegaard, Il concetto dell’angoscia, in Sorën Kierkegaard, Opere, a cura di Cornelio Fabro, Sansoni Editore, Firenze 1972.
Attività
Che cosa significa che: la possibilità è la più pesante di tutte le categorie? Ti è mai capitato di riflettere su questo aspetto della possibilità? Sì o no, perché?
4. Dalla scelta al bene: quale collegamento?
Quando facciamo delle scelte, anche se non sempre ce ne accorgiamo, dentro di noi c’è un’idea di bene – qualcosa che crediamo possa renderci felici, realizzati, soddisfatti. Spesso questa idea nasce da segnali o promesse (pubblicità, consigli, modelli) che ci spingono a fidarci e a decidere. Ma queste promesse vengono davvero mantenute?
Rileggere le nostre esperienze ci aiuta a capire a cosa abbiamo dato fiducia e se quelle scelte ci hanno fatto davvero bene. Così possiamo imparare a distinguere meglio ciò che vale davvero da ciò che è solo apparenza.
Attività 1
Promesse non mantenute: guardiamo insieme alcune pubblicità famose (video o immagini) che contengono messaggi forti (es. Red Bull, Mulino Bianco, Apple, Nike…). Prova a riflettere:
- Quale promessa trasmette quella pubblicità?
- È una promessa realistica o illusoria?
- Mi ha mai influenzato nella scelta?
Attività 2
Il mio slogan di felicità: ogni studente inventa uno slogan pubblicitario che rappresenta la propria idea di felicità o benessere (esempio: “Vivi libero, scegli te stesso!”, “Con l’amicizia ogni giorno è speciale”) e lo costruisce con musica, tecnologia ecc… Poi lo condivide con i compagni e si discute insieme: che immagine di bene esprime? Da dove nasce?
5. Lettera di Carlo Maria Martini ai giovani che non ha incontrato
Nel 1990 l’Arcivescovo di Milano Carlo Maria Martini scrisse una lettera ai giovani che non ha incontrato; fra questi potresti esserci anche tu, perciò vogliamo suggerirti di leggere questa lettera, che trovi nel percorso cliccando qui!
Attività
Prova a scrivere una risposta all’appello di Martini, indirizzandola a Lui, come se, ancora oggi, gli fosse possibile riceverla davvero. Dopo aver scritto la tua lettera, decidi se vuoi condividerla con qualche adulto che rappresenta, per te, una guida nel tuo cammino di crescita.
6. Collegamenti interdisciplinari: alcune riflessioni sul bene
Filosofia
Per approfondire il significato filosofico del bene nella filosofia antica, confronta:
Platone, Repubblica, VI, 508 E – 509 B
Aristotele, Etica Nicomachea, I. 1, 1094 a 3
Letteratura
Brano “Il bene, il male, la bontà” tratto da Vasilij Grossman, Vita e destino, Adelphi, pagg. 353-355 e riportato nel percorso a cui puoi accedere cliccando qui.
Formazione/Piscologia
Jonathan Haidt, La generazione ansiosa: come i social hanno rovinato i nostri figli, Rizzoli, Milano 2024.
Matteo Lancini, L’età tradita. Oltre i luoghi comuni sugli adolescenti, Raffaello Cortina Editore, Milano 2021.
IL SECONDO PASSO
La coscienza interiore, cuore della persona
Obiettivo
La scelta morale si radica nella coscienza dell’uomo, la sua interiorità più profonda, il suo cuore. Si ritiene, perciò, necessario riflettere sul significato delle parole interiorità, coscienza e cuore – che cosa sono? a che cosa servono? sono la stessa cosa? – per avvicinare i giovani alla pratica del discernimento.
1. La coscienza
Leggi i brani di Carlo Maria Martini riportati nel percorso cliccando qui.
2. Il cuore
Leggi il brano di Carlo Maria Martini riportato nel percorso cliccando qui.
Attività
Una prima sintesi: individua due o tre parole che riassumono la riflessione che hai appena fatto. Confrontati con i compagni e costruite insieme una nuvola di parole utilizzando questo link.
Dalla nuvola che avete realizzato si evincono le parole che vi accomunano o differenziano. Con l’aiuto del docente, provate a riflettere sul loro significato.
3. Libertà da, libertà di, libertà per…
Siamo giunti a una conclusione: alla parola libertà si attribuiscono significati molto diversi. Difficile trovare cosa hanno in comune espressioni tipo: tempo libero o libera professione, ingresso libero o libero pensiero, uomo libero o uomo che si prende delle libertà. Possiamo tentare un chiarimento distinguendo e integrando la nozione di libertà alla luce di tre prospettive:
- Libertà da (costrizioni)
- Libertà di (scegliere tra diverse opzioni)
- Libertà per (impegnarsi in vista del bene proprio e altrui)
- Da: vincoli e determinismi a cui sono invece sottoposti per es. gli animali, governati dei loro istinti. La persona umana è invece certamente sottoposta a dei condizionamenti, ma può anche modificare il modo di assumerli e utilizzarli come punto di appoggio per la decisione di un passo liberamente compiuto. È qui che emerge il secondo significato.
- Di: la persona si sperimenta capace di optare per un comportamento a cui attribuisce maggiore rilievo rispetto ad altre alternative possibili. Questo non vuol dire essere svincolato da ogni forma di influsso esterno o interiore (passioni, ignoranza, ecc.), ma di avere una gamma di possibilità all’interno della quale è possibile operare una scelta.
- Per: il compimento della libertà avviene non nella logica della fuga o nell’illusione di essere indipendenti da ogni legame, ma anzi nella capacità di assumersi delle responsabilità (naturalmente proporzionate alle proprie caratteristiche). Paradossalmente se il primo modo della libertà è di fuggire quanto viene percepito come un limite, la libertà matura si esprime assumendo dei vincoli costruttivi: pensiamo all’amicizia (che conduce a stare vicino all’amico in difficoltà, piuttosto che uscire a svagarsi), o alla parola data (che osservo lealmente, anche quando non mi è – più – conveniente), o alla vita professionale (il medico che continua a curare i propri pazienti anche durante la pandemia, mettendo a rischio la propria salute). Alla comprensione di questa nozione di libertà ci orienta la Bibbia nel modo in cui ci presenta l’alleanza: un vincolo che Dio assume nei confronti degli esseri umani, a cui rimane fedele anche quando ne va della sua vita.
IL TERZO PASSO
Il discernimento
Obiettivo
Riconoscere come e fino a che punto in un comportamento umano, proprio o altrui, in un fenomeno storico, in una scelta comunitaria viene realizzato il bene. Attraverso l’ascolto di un podcast, si invitano i giovani a prendere coscienza dell’importanza dell’esercizio del discernimento.
1. Primo podcast
| Il discernimento etico e spirituale |
2. Secondo podcast
| Diventare Grandi – Il Discernimento |
Attività
Esercizio di discernimento
Tutti i giorni, per una settimana, o anche più a lungo se lo desideri, nell’arco della tua giornata, ritaglia una mezz’ora di silenzio, durante la quale, in un luogo per te tranquillo, provi ad annotare su un quaderno, in due colonne distinte, le azioni e i sentimenti positivi e negativi che hai fatto o provato.
Al termine della settimana, prova a tracciare un bilancio generale dei passi avanti e di quelli indietro che hai compiuto.
IL QUARTO PASSO
L’incontro con l’altro che mi sollecita
Obiettivo
Invitare i giovani a comprendere come la presenza dell’Altro sia occasione di crescita individuale e comunitaria: è l’Altro che, anche nella mia indifferenza alla sua presenza, mi mette davanti ad una scelta concreta: come rispondo al suo appello?
1. Rispondere all’Altro: relazione e responsabilità
La vita viene vissuta in un sistema di presenze e relazioni con gli Altri dalle quali non si può prescindere. Alla luce di ciò è bene provare a capire come e che cosa desideri fare per gli Altri e ricevere dagli Altri. Prova a riflettere aiutandoti con queste domande:
- Cosa mi piacerebbe che gli Altri facessero a me?
- Cosa ritengo giusto che gli Altri tengano presente nei miei confronti?
- Che impatto ha questo sul mio modo di considerare e trattare gli Altri?
Queste semplici domande aprono alla questione della responsabilità: incontrare l’Altro non mi lascia altra possibilità che rispondere qualcosa, non ho scelta se rispondere o no; in qualunque modo io agisca o parli, sto dando una risposta. Sia che mi chieda qualcosa esplicitamente, sia che lo faccia implicitamente, anche nelle cose più banali: passare da una porta, passo prima io o lascio il passo? accolgo l’Altro e ascolto per quel che vuole dirmi o tiro dritto secondo il mio progetto? è un fatto costitutivo: è Abele che costituisce fratello Caino, che prima era da solo; è con l’arrivo di Abele che Caino si trova a essere responsabile (prendendo poi una via distruttiva-omicida).
Attività
Esercizio di discernimento
Di quale Altro/Altri ti senti responsabile? Sapresti indicare i motivi di questa tua responsabilità e la modalità attraverso la quale la eserciti? Confrontati con i compagni.
2. Il ruolo delle cose e dei beni nella relazione con gli altri
Le cose – i beni – sono mediazione della relazione con gli Altri: da come le uso si vede in che considerazione tengo gli Altri e come li tratto (nemici, competitori, antagonisti, fratelli o sorelle, amici…).
L’ambiente: le risorse naturali sono le condizioni di vita anche per gli Altri.
Attività
Collegati a un altro percorso Educational: Sostenibilità
3. Approfondimento: l’empatia in Edith stein
Hai mai sentito pronunciare la parola empatia? Sai cosa significa e come sia possibile essere persone empatiche, cioè capaci di empatia?
Prova a farti aiutare dalle parole di Edith Stein, leggendo il brano tratto dal volume Il problema dell’empatia che trovi nel percorso cliccando qui.
Attività
Per sperimentare che cosa significa stabilire una relazione empatica con le persone o vivere empaticamente, ti proponiamo un compito di realtà un po’ impegnativo: prova a costruire un dialogo con una persona con la quale non hai mai avuto contatti diretti (un compagno di classe, di sport, un vicino di casa, un professore…), durante il quale cercherai di individuare i suoi sentimenti per provare a vivere almeno uno di essi, a fartene carico empaticamente.
IL QUINTO PASSO
La regola aurea
Obiettivo
Muovendo dall’enunciato della regola aurea, si avvia una riflessione sulla struttura costitutivamente relazionale della soggettività umana, tesa a sottolineare la distinzione fondamentale tra l’etica e il diritto
1. L’enunciato della regola aurea
[…] nel momento in cui ci rendiamo conto che quanto vogliamo per noi (cioè che non ci venga fatto nulla di male e di ingiusto) vale pure per gli altri, nasce quel senso di giustizia che si esprime nella regola aurea. La regola del non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te: mi pare sia questa la formula più embrionale della percezione della giustizia o dell’ingiustizia.
C. M. Martini, La giustizia della Croce, in Carlo Maria Martini, Cattedre dei non credenti, Bompiani, Milano 2015, p. 1191
Volendo esprimere la regola aurea in senso positivo e propositivo, è possibile affermare: quello che desideri gli altri facciano a te, tu fallo agli altri. La proposta della regola aurea invita a una scelta etica che si distanzia da ogni prospettiva individualista e utilitarista.
2. La fondamentale distinzione di etica e diritto
[…] richiamo, con un esempio, la caratteristica dell’etica […], cioè il suo trattare di quelle azioni che sono assolutamente degne o indegne dell’uomo. […]
Mentre l’etica è la dottrina che si interessa degli atteggiamenti di valore dell’uomo, il diritto è l’insieme delle norme positive che le società si danno per rispondere a questi imperativi profondi e tradurli nella pratica quotidiana. Da solo, però, il diritto non garantisce un’etica pubblica: esso è un insieme di norme esterne che suppongono un consenso fondamentale dei cittadini sui grandi atteggiamenti che regolano i rapporti tra persone. quando comincia la discordia sugli atteggiamenti di fondo, ad esempio sul rispetto della vita, una società è minacciata di disgregazione e, alla lunga, non riuscirà più a darsi norme di diritto capaci di assicurare il rispetto di tutti.
Carlo Maria Martini, Viaggio nel vocabolario dell’etica, Edizioni Piemme, AL 1993, pp. 17-18.
Se il diritto si interessa soprattutto dei comportamenti esteriori, l’etica prende in conto anche la matrice dell’agire esteriore, che è dentro di noi.
Carlo Casalone SJ, inedito.
Riflessioni
Ora che hai letto i due brani proposti, ti invitiamo a riflettere su quanto segue:
La coscienza formata individua nella norma un valore da tutelare, non (solo) una limitazione del comportamento e della spensierata espansione dell’io.
Ma i valori arrivano sempre insieme nelle singole situazioni in cui ci troviamo coinvolti nella nostra esistenza (per esempio: non uccidere e difendi la vita dell’ingiustamente aggredito; utilizza i trattamenti per curare la malattia di questa persona e alloca le risorse limitate in modo giusto; dedicati al servizio degli altri e prendi tempo per il tuo benessere; …).
Per non perdersi nell’urgenza e nella complessità delle situazioni in cui siamo quotidianamente coinvolti, occorre entrare nella logica del bene maggiore possibile e di un’osservanza della legge che non si limita alla lettera della legge, ossia alla messa in pratica in maniera a-critica, sempre e dovunque, di quanto essa prescrive, solo perché è una legge. Anche Gesù trasgredisce il sabato o lo interpreta più profondamente, in modo responsabile, realizzandone il compimento.
3. bene comune e principio di responsabilità
Lasciati guidare dalle parole dell’Arcivescovo Martini che ti aiuteranno a chiarire il significato del sintagma bene comune e la sua correlazione con quel principio di responsabilità che ci chiama costantemente in causa, innanzitutto come persone e anche come cittadini. Entra nel percorso e leggi il brano tratto dal Viaggio nel vocabolario dell’etica.
Approfondimento
Per approfondire il tema della responsabilità, entra nel percorso e leggi il brano tratto dal volume di Hans Jonas, Il principio responsabilità.
Attività
Conosci la vicenda del Samaritano? Se non la conosci, fai una ricerca. Questa vicenda ti permette di mettere a fuoco i passaggi fondamentali che abbiamo percorso fino a qui riguardo alla risposta che ciascuno di noi dà quando incontra l’Altro. Il levita e il sacerdote vedono e tirano dritto, cioé rispondono (qualcosa rispondo sempre, anche quando non mi fermo) di fatto e a priori che hanno qualcosa di più importante da fare; il samaritano si ferma, riconsidera il suo progetto alla luce dell’incontro e dà una risposta secondo i propri mezzi, poi riprende il suo viaggio.
Testo argomentativo: cerca un fatto di cronaca e prova a domandarti come avresti risposto tu, se ti fossi trovato in medias res, cioè coinvolto personalmente e direttamente nella vicenda: avresti fatto come il levita e il sacerdote o come il samaritano? Perché? Secondo quali criteri?
Collegati a un altro percorso Educational: Giustizia.
IL SESTO PASSO
Proposte operative conclusive per una possibile applicazione pratica di quanto è stato appreso e maturato
Obiettivo
Dopo aver affrontato il percorso, nella sua interezza o anche solo parzialmente, prova a mettere in pratica quanto hai appreso a proposito di un quesito di bioetica particolarmente attuale e importante.
1. Bioetica e Comitato nazionale di bioetica, cosa sono?
2. Proponiamo alcuni temi di riflessione in ambito bioetico

